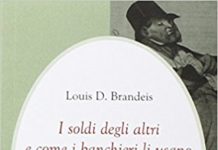di Aldo Bonomi –
 La prima e più devastante crisi economica dell’era globale impone a tutti un ripensamento. L’esito catastrofico di un trentennio dominato dai dogmi di un liberismo estremo spinge per soluzioni nuove e impensate, ma ripropone anche pulsioni conservatrici e impossibili ritorni al mondo che abbiamo perduto oppure suggerisce ingannevoli vie di fuga verso l’utopia. Il patto fra democrazia e capitalismo va ripensato. Non ci sono scorciatoie. Il cambiamento va pensato e prodotto in corsa, gli elementi di un nuovo modello economico e sociale vanno estratti dalla materia incandescente dei processi in atto. Qui e ora, non in un futuro che non arriva mai, ma nello spazio incerto e rischioso del possibile.
La prima e più devastante crisi economica dell’era globale impone a tutti un ripensamento. L’esito catastrofico di un trentennio dominato dai dogmi di un liberismo estremo spinge per soluzioni nuove e impensate, ma ripropone anche pulsioni conservatrici e impossibili ritorni al mondo che abbiamo perduto oppure suggerisce ingannevoli vie di fuga verso l’utopia. Il patto fra democrazia e capitalismo va ripensato. Non ci sono scorciatoie. Il cambiamento va pensato e prodotto in corsa, gli elementi di un nuovo modello economico e sociale vanno estratti dalla materia incandescente dei processi in atto. Qui e ora, non in un futuro che non arriva mai, ma nello spazio incerto e rischioso del possibile.
L’importante contributo di Aldo Bonomi, sociologo, direttore dell’AASTER di Milano, apre il dibattito, suggerendo la via d’uscita di una Green economy non ingenua, ma consapevole dei processi globali e attenta al territorio. Nei prossimi giorni, pubblicheremo altri interventi, a partire da quello di Lapo Berti.
La crisi come metamorfosi
La macina della grande trasformazione da cui origina la crisi sta arrivando ad un punto di svolta. Vengono al pettine i nodi di un lungo ciclo neoliberista che ha scardinato gli equilibri consolidati tra politico, sociale ed economico. L’egemonia della finanza globale ne è stata il fluido corrosivo, prima con il volto suadente dell’inclusione “via subprime”, oggi con quello inquietante di uno stato d’eccezione che azzera l’autorità del politico, precarizza le Costituzioni e liquefa le basi della sovranità intesa come spazio del welfare e dei diritti. Democrazia e mercato ritornano a percorrere strade divergenti. Lo smarrimento delle sinistre europee arresesi di fronte all’esplosione della bolla dei debiti sovrani sta esattamente nell’aver perduto la cifra di fondo del rapporto tra questi due poli della civiltà occidentale. Per riprendere il bandolo della matassa dobbiamo capire anzitutto che l’attuale fase non può essere interpretata nei termini dell’attraversamento, della carovana nel deserto, quanto della metamorfosi: il sistema sta diventando altro e quindi anche i soggetti che vi agiscono devono radicalmente mettersi in discussione vivendo dentro le trasformazioni della polis, non delegando ai poteri della governance tecnocratica o ritirandosi nei paradisi artificiali del post-moderno e del post-ideologico. Facendo in primo luogo chiarezza. Dunque iniziamo con il dire che proprio sulla crisi e sulle sue possibili uscite mi sembrano all’opera oggi almeno tre ideologie anche se intese come forme di pensiero debole.
La prima ideologia sostiene che siamo di fronte ad una vera e propria crisi di sistema, ad un deragliamento generale che ha alla sua radice il rapporto ormai insostenibile tra civilizzazione e natura. La crisi è sistemica e dunque scorciatoie che ripropongano tal quale l’architettura del welfare novecentesco oggi sono difficilmente praticabili. E dunque anche i modelli di rappresentanza, le culture politiche, le forme di organizzazione dell’impresa come del lavoro devono essere coerenti con questa natura della crisi. Aveva ragione Braudel quando parlando dell’ascesa dell’Inghilterra a spese della potenza finanziaria olandese nel capitalismo di fine XVII secolo, suggeriva l’idea della transizione egemonica. E’ forse presto per sostenere con ferrea certezza ipotesi decliniste vista la potenza militare e finanziaria che l’asse atlantico continua a mantenere. Certo è che l’egemonia del pensiero occidentale pare in crisi. Viviamo probabilmente l’ultimo esito di un lungo ciclo partito con le decolonizzazioni degli anni ’50 e ’60 in cui la presa politico militare dell’Europa sul resto del mondo è stata definitivamente scossa. Oggi sono paesi europei ad essere visitati da missioni di “salvataggio” del Fondo Monetario Internazionale o a mandare missioni a Pechino o nelle altre capitali dei BRICS per proporre l’acquisto di pacchetti del debito pubblico europeo ai fondi sovrani. Se l’analisi può essere condivisibile, è però la proposta del paradigma della “decrescita felice” come uscita che mi lascia piuttosto perplesso. La dico con una battuta: a meno di non considerarla una innocua forma di prosumerismo da lasciare alla libera iniziativa individuale, sarà necessario utilizzare i carri armati nelle strade per applicare la decrescita sistemica. Anche la posizione di chi sostiene “ma perché dobbiamo pagare noi il debito?” mi pare non tenga conto che il default lo pagherebbe la parte più debole. In questa galassia la posizione importante mi pare invece quella degli indignati americani con l’intuizione del 99 % contro l’1 %, sorta di interclassismo della moltitudine che mostra come la crisi odierna non tocchi solo i ceti proletari del ‘900 ma anche i ceti medi: in Italia il 10 % della popolazione detiene oggi il 50 % della ricchezza. Potenzialmente la base per un’alleanza sociale non fosse che, come ha giustamente osservato R. Rossanda, quel 99 % è massa senza classe priva ancora di coscienza dell’essere soggetto. Un passaggio che esige la rimessa a tema della rappresentanza e delle sue funzioni nell’epoca della crisi democratica. Fino ad arrivare ad una nuova costituzionalizzazione di un rapporto tra politica e mercato che ne incorpori il diritto/responsabilità di governare il mercato, non di governare per il mercato o di governare a causa del mercato come oggi accade con il Governo Monti.
La seconda posizione è quella che potremmo definire “della morfina tecnocratica”, che sostiene che in fondo non è accaduto nulla, che occorre soltanto compiere aggiustamenti strutturali dei mercati per accompagnare il sistema al suo nuovo equilibrio di mercato. Per breve tempo è stata anche una ipotesi credibile ad inizio secolo con una finanza che si presentava come canale di integrazione in mercati aperti a tutti. L’attuale governo è almeno in parte espressione diretta di quelle tecnicalità che avevano gestito proprio quella fase. Il tutto dentro la crisi di una politica che non ha saputo cogliere l’occasione di ridisegnare il proprio ruolo in modo non ancillare rispetto all’economia. Cedendo il passo al mito del governo degli ottimati. Un passaggio su cui andrebbe riflettuto anche in termini di equilibri interni alle borghesie di questo paese perché è evidente che l’ascesa di élite centrali e metropolitane come quelle che costituiscono il Governo Monti segna per molti versi il tramonto dell’egemonia di una neoborghesia diffusa del capitalismo molecolare e dei distretti. Mettendo in tensione come mai dalla nascita delle liberaldemocrazie di massa il rapporto tra mercato e democrazia. Tensione che porta con sé il tema della “costituzione abortita” nel senso della costituzione europea. Su questo punto bisogna essere chiari: non si va oltre l’ipotesi della morfina tecnocratica se non si abbraccia pienamente una prospettiva di democrazia europea.
E dunque, tra questi due poli non ci può essere lo spazio di una faticosa “terza via”? Penso che dentro la metamorfosi di un capitalismo che si ridisegna si può ragionare su una uscita del dopodomani utilizzando il concetto di “green economy”. Concetto ormai precocemente abusato, me ne rendo conto. Spesso utilizzato come scatola semantica buona per tutti i contenuti e gli usi. Con forti margini di ambiguità e sovrapposizione anche rispetto alle due ideologie alternative appena accennate. Green economy è in primo luogo il capitalismo che incorpora il limite ambientale nel suo processo di accumulazione. Ne fa motore di un nuovo ciclo. E’ un discorso che incorpora il tema della sobrietà dei consumi e di una nuova strategia keynesiana di nuovi investimenti. Tuttavia l’idea di green economy se situata nelle condizioni reali del ciclo capitalistico che stiamo vivendo, può aiutarci a ricostruire su basi nuove filamenti di rappresentanza fuori dalle secche della governance. Per evitare equivoci però il concetto va spacchettato, smontato dall’interno. Perché a ben vedere ne possiamo identificare almeno tre versioni, le quali assumono significati ed esiti politici opposti tra loro.
In primo luogo, green economy sul piano delle economie mondiali è anche una grande bolla finanziaria (la prossima?) con la finanziarizzazione delle commodities alimentari e l’accaparramento delle terre agricole in Africa e in America Latina per produrre combustibili alternativi al petrolio in via di esaurimento. E’ di fatto una forma di neocolonialismo nel tempo della finanza globale che sta conducendo all’esplosione dei prezzi delle risorse vitali ed è stata una delle scintille di esplosione delle rivolte nordafricane nell’anno che si chiude. Al polo opposto esiste anche una seconda declinazione di green economy, legata all’idea di una diversità dei modelli di capitalismo e, nel caso dell’Italia, alla radice territoriale e localistica del nostro apparato produttivo. Una green economy territoriale, dal basso, che segue tre canali. Il primo è l’evoluzione del capitalismo molecolare, come adattamento delle economie produttive di piccola e media impresa sul lato della compatibilità ambientale delle produzioni, di una innovazione leggera dei processi produttivi e del design dei prodotti. Il secondo l’evoluzione di una tendenza al vivere “borghigiano”, la propensione ad una migliore qualità localistica della vita tipica dello spleen metropolitano di ampi segmenti di ceto medio riflessivo protagonista a partire dagli anni ’90 di una evoluzione postmaterialista degli stili di vita e di consumo. Che fa da base sociale e culturale a fenomenologie come Slow Food, Eataly, reti e accademie del gusto proliferate sul territorio, ecc. Un fenomeno che riattiva e incanala sul mercato tradizioni locali, a cavallo tra economia e rappresentazione sociale che organizza filiere produttive e nel medesimo tempo ha sbocchi di tipo partecipativi e democratici importanti. Terzo, green economy dal basso è anche nuovo lavoro, inteso sia come problema di una nuova qualità del lavoro che come nuova composizione sociale e nuovi bisogni. E’ l’emersione di pratiche di mutualismo che affrontino l’impatto della crisi del debito sulla vita quotidiana, riguarda la capacità di tutela e gestione partecipata dei beni comuni, delle reti, dello stesso credito, organizzandola a livello locale dentro le città e nei territori.
In mezzo tra finanza e territorio si colloca una visione della green economy che, in mancanza di etichette più adeguate, definisco neo-keynesiana e che per quanto mi riguarda rappresenta la vera sfida se si vuole rimettere con i piedi per terra il rapporto tra capitale e democrazia. Si tratta di pensare ad una terza rivoluzione industriale che abbia come scopo quello di spingere in avanti la frontiera della discontinuità tecnologica ad esempio sul piano della questione energetica per sostituire un’era del combustibile fossile e della chimica derivata. Ma per farlo occorre la costituzione di infrastrutture e di poli che abbiano la massa d’urto adeguata. E’ chiaro che tutto ciò significa ripensare il ruolo del pubblico fuori sia dai vecchi schemi dell’Iri che dalle retoriche neoliberiste. Un ruolo che va declinato a cavallo tra centro e periferia del sistema. In Italia abbiamo poli di eccellenza su questo fronte, non siamo all’anno zero. Al centro le grandi aziende come ENI, ENEL, la cui funzione deve essere discussa, sul territorio la rete delle multiutilities eredi delle vecchie municipalizzate rappresentano punti di possibile ancoraggio. Un neo-keynesismo che dovrebbe tuttavia avere come punto centrale non l’accentramento nelle mani dello stato-nazione quanto la capacità dei poli d’eccellenza di fungere da fertilizzatori della green economy territoriale con un nuovo rapporto centro-periferia.
Una sfida che può rimettere a tema la capacità della rappresentanza politica di governare i processi. Senza la quale la partita tra democrazia e tecnocrazia rischia di essere già decisa.