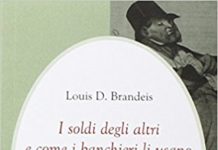Italia: una crisi che non finisce
di Lapo Berti –
 Il cambiamento, tramite una serie infinita e ininterrotta di adattamenti, è la vita normale delle società umane. Ma vi sono momenti in cui il meccanismo s’inceppa, perché qualche pezzo di società ha accumulato sufficiente forza per sottrarsi al processo generale e per riuscire addirittura a bloccarlo. Quando interviene una crisi dall’esterno questa situazione diviene esiziale perché l’intero sistema rimane privo di risposte e la crisi si somma a crisi. E la via d’uscita, allora, può prendere la forma della catastrofe. E’ il caso dell’Italia
Il cambiamento, tramite una serie infinita e ininterrotta di adattamenti, è la vita normale delle società umane. Ma vi sono momenti in cui il meccanismo s’inceppa, perché qualche pezzo di società ha accumulato sufficiente forza per sottrarsi al processo generale e per riuscire addirittura a bloccarlo. Quando interviene una crisi dall’esterno questa situazione diviene esiziale perché l’intero sistema rimane privo di risposte e la crisi si somma a crisi. E la via d’uscita, allora, può prendere la forma della catastrofe. E’ il caso dell’Italia
Per quanto frutto di un equivoco, la storiella secondo cui in cinese per rappresentare la nozione di crisi si userebbe un ideogramma, Wej.ji, che accosta due caratteri, uno dei quali significa “pericolo” e l’altro “opportunità” rimane intrigante proprio perché suggerisce la valenza ancipite delle crisi, che, da una parte distruggono, ma, dall’altra, aprono nuove strade, nuove possibilità. Anzi, senza le crisi non c’è vero cambiamento, perché, come scrisse una volta Albert Einstein, “Non possiamo pretendere  che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose”(*).
che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose”(*).
Non tutte le crisi, tuttavia, manifestano questa valenza positiva, questa forza rigeneratrice. Spesso quelle che definiamo crisi sono semplicemente delle sequenze di eventi percepiti come negativi perché danno luogo a una situazione peggiore di quella precedente, cui, tuttavia, si finisce con l’abituarsi. È questo il caso della maggior parte delle crisi economiche, che si chiudono generalmente con il ritorno al sentiero di crescita affermatosi in passato in una prospettiva di lungo periodo. Altre volte, invece, quell’insieme di eventi cui si dà il nome di crisi genera una situazione che, per la sua persistenza e la sua gravità, viene avvertita dai più come intollerabile e si cominciano ad auspicare interventi radicali per porvi rimedio, in un modo o nell’altro. La domanda che si pone, allora, è: quanto deve essere profonda, persistente, una crisi per scatenare effetti positivi, per generare una rinascita?
È quello che viene inevitabile domandarsi di fronte alla crisi italiana. C’è, infatti, la sensazione, sempre più diffusa anche se avvertita in maniera vaga e ancora insufficiente, che solo un’evoluzione della crisi verso esiti catastrofici possa produrre reazioni così forti da aprire la strada al suo superamento. Insomma, l’antica saggezza popolare secondo cui, in certe situazioni, bisogna toccare il fondo per risollevarsi.
Proviamo a dare sostanza a questa sensazione. Il punto cruciale è che il sistema italiano nel suo complesso, nella sua configurazione attuale, sembra non sia in grado di esprimere le energie necessarie al superamento della crisi. Tutti avvertiamo che la discontinuità necessaria è grande, ma all’orizzonte non si vede nessuno in grado di produrla e di guidarla.
Questo vale, in primo luogo, per il sistema politico, che si avvita ormai da tempo in un tentativo senza speranza di mantenere le posizioni di potere e gli equilibri acquisiti, senza riuscire a rimettere in moto il motore democratico del consenso. La corruzione, che finora ha costituito il principale strumento di conservazione del potere, ha prodotto una delegittimazione dei partiti e del ceto politico che ha superato il punto di non ritorno. I discorsi più o meno fraintesi o boicottati sulla rottamazione non fanno che esprimere la necessità di una trasformazione radicale dei meccanismi della rappresentanza democratica e, soprattutto, dei rappresentanti stessi, ormai nominati all’interno di un circuito oligarchico che si regge all’insegna della “peggiocrazia” (Zingales). Anche i tentativi, pur meritori e apparentemente riusciti, di ricostituire una connessione fra cittadini e partiti, come le primarie del centro-sinistra, non sembrano in grado di produrre quella forte discontinuità di cui ci sarebbe bisogno. Non si vedono ancora i segni di quella possibile composizione di un campo progressista a forte vocazione democratica e liberale che solo potrebbe por fine all’infinita transizione italiana. Sembra prevalere l’idea di un cambiamento temperato, che non produca rotture irreversibili negli aggregati di potere, ma solo una loro lenta dislocazione verso equilibri che lascino sostanzialmente intatta la governance.
Ma vale anche per il sistema economico, al cui vertice si trova un management largamente inadeguato, che, salvo un ristretto numero di eccezioni, non ha saputo leggere i cambiamenti in atto nell’economia globale e trovare le vie di una nuova specializzazione produttiva al riparo della concorrenza internazionale sul costo del lavoro. Un’economia in cui le imprese, non tutte per fortuna, si sono abituate a ricercare la protezione e i soldi dello stato invece di attrezzarsi per competere e per entrare a far parte di reti competitive. Un’economia in cui i grandi imprenditori privati hanno cercato rifugio nella rendita degli ex monopoli pubblici che, sotto gli occhi di un antitrust accondiscendente se non colluso, si sono trasformati in monopoli privati. Un’economia in cui la cultura della concorrenza ancora stenta ad attecchire perché le imprese domestiche sono soprattutto impegnate ad aggirarla e chi ne dovrebbe far rispettare le regole è succube della politica da cui dipende la sua carriera e dai potentati economici che condizionano la politica. Un’economia composta in gran parte da un capitalismo clientelare che ancora rimpiange le svalutazioni competitive della lira e piange per il costo eccessivo del lavoro, ma non investe, se non alla ricerca di rendite finanziarie, e non innova. Certo, dentro l’economia italiana ci sono anche imprese sane e dinamiche che, mentre le altre lamentano la crisi dei consumi, si fanno spazio sui mercati internazionali e riescono a crescere anche nelle fasi più dure della crisi. Ma non riescono ancora a esprimere un’egemonia politica tale da imporre un cambiamento radicale di prospettiva.
E vale, infine, anche per la società, in cui sono prevalsi comportamenti ispirati a un individualismo mascalzone che fa dell’accaparramento di ricchezza, con qualunque mezzo, il criterio supremo del successo. Una società che si è lasciata trasformare nel paradiso dei furbi, che ha dilapidato il patrimonio di civismo accumulato nel corso dei secoli, alla ricerca del successo e della ricchezza in un’ottica miope di breve e brevissimo periodo. Una società sempre più insofferente di regole e valori condivisa, chiusa nel suo facilissimo amorale. Una società che rifugge dal confronto meritocratico, abituata a contare sulla più rassicurante ragnatela dei rapporti nepotisti e clientelari, in cui basta rinunciare alla dignità e si può ottenere qualsiasi cosa. Una società, quindi, in cui il sapere e la professionalità, lo spirito di sacrificio, la stessa passione civica, sono valori irrisi, sacrificati sull’altare di una mediocrità diffusa e trionfante. Una società in cui il senso della coesione e della condivisione è sempre più affidato all’azione dei singoli o di gruppi che se ne fanno meritoriamente portatori, ma non è più patrimonio di tutti, non è più l’humus di cui si nutre la vita collettiva. Una società, infine, che ha perso il gusto di essere protagonista, che, in tutto, preferisce il ruolo di spettatore, tutt’al più di tifoso. Certo, la nostra è anche una società che sa tuttora esprimere grandi individualità, che sa dare vita a splendidi esempi di cooperazione, d’invenzione, d’innovazione, in cui ancora esistono risorse umane di tutto rispetto, ma che, nel suo insieme, non sa darsi un progetto, non riesce a trovare una sua identità collettiva. Ed è anche una società che nasconde dentro di sé un enorme bacino di energie giovanili cui non sa attingere, perché è incapace di rinnovarsi e punta tutto sulla conservazione. Ma, anche qui come nell’economia, le forze sane, innovative, non riescono a fare corpo, non riescono a darsi una rappresentanza politica chiara e univoca, capace di prospettare un futuro al paese.
Siamo un paese in cui, nonostante tutto, la speranza non è ancora morta, ma dove le energie più vive e dinamiche rischiano di essere portate a fondo da quelle parti, non piccole, della politica, dell’economia, della società, che sono abbarbicate alla conservazione di un presente che non c’è più perché se lo sono divorato e combattono ferocemente contro ogni tentativo di spodestarle dalle posizioni di rendita e di privilegio, piccole e grandi, in cui si sono arroccate. A meno che…
A meno che una catastrofe non faccia saltare il fondamento su cui poggiano le forze della conservazione e dell’immobilismo, trascinando con sé il sistema di relazioni incestuose, collusive, politicamente gelatinose, che ne costituiscono la struttura portante. Non sto pensando a un terremoto distruttivo, a un’inondazione travolgente, a un improbabile tsunami. Sto pensando alla catastrofe che ci stiamo inconsapevolmente ma inesorabilmente apparecchiando con le nostre mani a forza di colpevoli inerzie; alla catastrofe che può derivare dalla esiziale incapacità di prendere decisioni, di affrontare i problemi, di dare risposte. È la catastrofe che si può produrre quando una massa soverchiante di problemi esige di essere risolta contemporaneamente, perché le forze dell’economia non ce la fanno a riprendere il sentiero della crescita, la politica non riesce a rendere credibile una prospettiva di futuro, la società s’incattivisce perché si sente defraudata, senza speranza. È la catastrofe che si può determinare perché un numero crescente di persone perde la speranza, perché viene meno la fiducia e il contesto sociale si disgrega. Dopo un ventennio di fuga dalla realtà, accecati dalle fantasmagoriche promesse di un magnate che pensava solo al suo tornaconto, incapaci d’imporre un discorso di semplicità e di trasparenza, può essere che la realtà si riprenda la scena. E non può farlo se non con il fragore di un rovesciamento di prospettiva che muova le persone e le porti a riappropriarsi con rabbia di tutto ciò di cui si sono lasciate derubare, a partire dalla dignità; con la fermezza di una volontà di cambiamento capace di spazzare via una volta per tutte la ragnatela di clientele, di favori occulti, di privilegi, di connivenze, che avvolge il paese e lo fa marcire; con la forza trascinatrice di una voglia d’innovazione che riporti gli individui a scommettere sulle loro capacità. Se questo avvenisse, sarebbe una catastrofe, ma dietro le nubi comincerebbe finalmente a splendere il sole.
Ciò che genera situazioni quasi-catastrofiche in un contesto sociale è, generalmente, una sorta di coazione a riprodurre comportamenti sbagliati, che già da tempo sono stati fatti oggetto di critiche e di avvertimenti, che già hanno vissuto i loro fallimenti, ma che i soggetti che li adottano non vogliono o non sono in grado di mutare perché questo significherebbe sottrarsi alla logica del sistema cui appartengono e da cui traggono il loro ruolo. Non mancano, in questi giorni, i segni deprimenti di questa deriva. In questi casi, perché possa aprirsi la strada di un cambiamento occorre che s’instauri la sindrome dell'”ultimo giro”. Solo in questa condizione può succedere che la comprensione degli eventi diventi sufficientemente chiara e la volontà di affrontarli sufficientemente forte da produrre il cambiamento radicale che è necessario. La catastrofe è l’ultima speranza.
____________________
(*) E continuava: “La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla”. (Il mondo come io lo vedo, 1931)