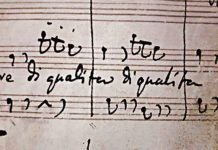Considerazioni sulla qualità della vita in tempi di turbolenza
Il termine forse più usato e abusato negli anni o decenni passati è quasi certamente “crisi”. Lo si è declinato in un’infinità di modi. Si è parlato di crisi politica, di crisi economica, di crisi finanziaria, di crisi fiscale, di crisi ambientale, di crisi sociale, di crisi morale, di crisi religiosa. Di un’ulteriore e possibile declinazione non si è parlato o si è parlato molto poco, quasi incidentalmente, o, addirittura non si è voluto parlare: di crisi di civiltà
Una crisi di civiltà?
Il termine forse più usato e abusato negli anni o decenni passati è quasi certamente “crisi”. Lo si è declinato in un’infinità di modi. Si è parlato di crisi politica, di crisi economica, di crisi finanziaria, di crisi fiscale, di crisi ambientale, di crisi sociale, di crisi morale, di crisi religiosa, di crisi di fiducia; di crisi di nervi, verrebbe da aggiungere. Di un’ulteriore e possibile declinazione non si è parlato o si è parlato molto poco, quasi incidentalmente, o, addirittura non si è voluto parlare: di crisi di civiltà. Eppure, è forse questa la prospettiva che ci consentirebbe di considerare e di comprendere più in profondità le tante crisi che ci angosciano e, più in generale, le dinamiche sociali, economiche, politiche lungo le quali sta scivolando la nostra civiltà. Il grande antropologo Ernesto De Martino vi avrebbe forse trovato la materia per delineare un’ennesima “apocalisse culturale”.
Forse, come l’ambiente fisico in cui viviamo, anche l’ambiente sociale è soggetto all’alternanza di ere calde o temperate in cui la vita fiorisce e si espande e di ere glaciali in cui la vita si ritira e combatte duramente per conservarsi. La sensazione cui vorrei offrire il supporto di qualche riflessione più accurata è che ci stiamo avviando verso una sorta di glaciazione sociale, perché stanno venendo meno alcune delle spinte vitali, espansive, che hanno sospinto la precedente fioritura.
Parlando di quella che ha definito la “grande stagnazione” del proprio paese, un economista americano, Tyler Cowen, ha sostenuto che la società americana, negli ultimi tre secoli, si è mangiata tutti i “low-hanging fruits”, i frutti a portata di mano, che quella terra e la sua storia fortunata gli avevano offerto. Forse è una considerazione che vale non solo per gli americani, ma per noi tutti e descrive bene la natura dello sviluppo economico che ha fatto apparentemente prosperare le nostre società (occidentali).
Sono finiti i “frutti a portata di mano”
Abbiamo a lungo sfruttato i frutti di una terra generosa, che ci ha offerto cibo e materie prime per alimentare un grandioso sviluppo delle nostre capacità economiche e della nostra ricchezza individuale e collettiva. Dalle viscere della terra abbiamo scavato una quantità pressoché incommensurabile di energia, che ha moltiplicato le nostre capacità e possibilità. L’offerta era così abbondante che appariva illimitata, suscitando l’illusione, incarnata dalla cultura del progresso, che il modello di crescita della ricchezza che avevamo individuato, sotto il nome di capitalismo, potesse rappresentare il destino eterno dell’umanità.
Ma non ci siamo limitati ad arraffare in maniera sconsiderata i frutti a portata di mano. Abbiamo anche posto le basi per cambiamenti di sistema irreversibili, suscettibili di intaccare, se non distruggere, le fondamenta materiali su cui poggia la nostra civiltà e quelle ancora più fragili su cui abbiamo eretto la convivenza sociale.
Questo è il rischio spaventoso cui lo sviluppo della nostra civiltà sta esponendo la società degli uomini. È il rischio faustiano cui l’imponente sviluppo della scienza e delle forze produttive innescato dalla rivoluzione industriale sta esponendo il nostro ambiente fisico e di conseguenza anche quello umano. Siamo ormai entrati nell’antropocene, come l’hanno definito alcuni studiosi, un’era nuova e sconvolgente che proietta la nostra sopravvivenza in un quadro futuro che sovverte l’ordine fisico che ha finora accompagnato e sostenuto il cammino della civiltà umana. Per la prima volta nella storia del nostro pianeta, l’azione dell’uomo, che pure ha sempre inciso, trasformandolo, sull’ambiente naturale, senza peraltro turbarne gli equilibri sistemici, è oggi in grado di mutare gli assetti dell’ecosistema terra, addirittura di governare e trasformare i processi naturali. Fino a oggi era l’uomo, in linea di massima, ad adeguarsi alle dinamiche naturali, tentando di piegarle ai propri fini, oggi è la natura che deve provare ad adeguarsi alle dinamiche messe in moto dall’uomo. È un rovesciamento radicale del rapporto uomo-natura, che stenta a trovare un modo altrettanto radicale di cambiare i nostri comportamenti e i modi in cui pensiamo e progettiamo l’evoluzione dell’ambiente terrestre.
La dissipazione del capitale sociale
Il capitalismo non è solo un grande divoratore di risorse ambientali; è anche un grande, spietato, divoratore di risorse sociali e umane.
Abbiamo attinto, senza nemmeno rendercene conto, all’immenso patrimonio sociale e culturale accumulato nel corso di millenni dalla nostra civiltà. Quello che alcuni sociologi ed economisti, con felice intuito, hanno chiamato “capitale sociale”, ovvero quell’insieme complesso e variegato di soluzioni oggettivate in istituzioni o trasfuse nelle abitudini, nei modi di sentire e di comportarsi delle persone, che hanno costituito la solida intelaiatura della nostra civiltà, garantendo la coesione sociale e la convivenza pacifica tra i membri di una società composta di estranei. Il capitale sociale rappresentava il patrimonio delle esperienze ereditate da millenni di sforzi e di ricerche per rendere migliore la vita dell’umanità. Esso ha costituito il fondamento di conoscenze, di capacità, di relazioni sociali, su cui è stato possibile costruire il grande progetto illuministico di un progresso continuo e illimitato delle capacità umane. Il capitale sociale è l’elemento costitutivo della qualità della vita.
Quel patrimonio è stato dilapidato. Più esattamente, è stato sacrificato sull’altare di quel moloch della modernità che è la crescita economica. Abbiamo affidato il nostro destino a un meccanismo potente quanto devastante che va sotto il nome di capitalismo. Esso ha rimesso in gioco, potenziandoli e in certa misura sublimandoli, gli impulsi primordiali che facevano sì che ogni uomo fosse un lupo per l’altro uomo: homo homini lupus, come segnalava Hobbes. L’egoismo, l’affermazione di se stessi, la conquista del potere sopra gli altri, la facoltà di disporre di tutto ciò che è a portata di mano per soddisfare i propri bisogni e le proprie voglie: questo groviglio di pulsioni che definiscono biologicamente la natura dell’uomo è stato trasposto, e solo in parte sublimato, nel grande gioco dell’economia. La società ha ricevuto in cambio la crescita economica, la soddisfazione di una quantità crescente di bisogni, l’apertura, spesso illusoria, di nuove prospettive di vita e di esperienza, ma ha dovuto impegnare quello che di più prezioso era riuscita a mettere insieme in millenni di esperienze traumatiche, di sofferenze, di lotte, di guerre: la convivenza pacifica fra individui che non si conoscono. L’individualismo esasperato che il capitalismo inevitabilmente promuove, perché nel grande gioco dell’economia gli uomini vincono solo in quanto individui, ha poco a poco corroso il tessuto sociale, esaltato l’estraneità che era stata appena domata, santificato l’egoismo contro la com-passione.
I risultati di questa devastazione del patrimonio più intimamente connesso con l’idea di civiltà, del capitale sociale, sono ormai solidamente installati all’interno degli ambienti urbani e si stanno diffondendo esponenzialmente. Poche generazioni saranno sufficienti a distruggere i risultati del faticoso quanto grandioso percorso di convivenza che ha impegnato centinaia di generazioni di uomini.
Il degrado dell’ambiente fisico e sociale delle nostre metropoli ne è l’esempio più vivo e drammatico. Da quando, non molti anni fa, si cominciò a notare l’emergere di un sempre più diffuso “livore metropolitano” (Dahrendorf), sintomo di una disgregazione già avanzata, del tessuto sociale, il processo di disfacimento ha ormai raggiunti livelli probabilmente irreversibili. Tutte le gradazioni dell’estraneità sono state sperimentate. Dall’indifferenza all’aggressività, dall’individualismo esasperato allo spregio dei beni comuni. Lo spazio pubblico, sia nella sua accezione virtuale che in quella concreta, si è ristretto fino a scomparire, trasformato sempre più spesso nel luogo di nessuno, una sorta di enorme discarica del malessere metropolitano. Tutto questo in un ambiente economico dominato e plasmato dalla crescita drammatica e, in apparenza, inarrestabile, delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza. Il mondo sembra appartenere a quelli che hanno di più, mentre quelli che hanno di meno sembrano scivolare sempre più in basso.
Certo, sarebbe un errore non vedere e non apprezzare quei nuclei di persone attive che, pur in minoranza, si sforzano tenacemente di tenere in mano il filo della coesione sociale. Ma sarebbe altrettanto un errore non vedere la fragilità e la precarietà di questi tentativi, sempre sul punto di essere spazzati via dal vento dell’indifferenza.
La società degli estranei
L’umanità ha impiegato migliaia di anni per riuscire a far convivere in pace milioni di sconosciuti. C’è voluto un tempo infinito perché, dopo la fine dell’ultima era glaciale, più di 10.000 anni fa, quel cugino stretto degli scimpanzé e dei bonobo da cui discendiamo si risolvesse ad abbandonare il suo atteggiamento violento, aggressivo, diffidente nei confronti degli altri e decidesse di dar vita a insediamenti stabili dove allevare animali e coltivare piante. L’uomo, Homo sapiens sapiens è così diventato “l’unico animale che si è impegnato in una complessa divisione di compiti fra membri della stessa specie non collegati geneticamente… La natura non conosce altri esempi di una simile, complessa, mutua dipendenza fra estranei” (Seabright 2004). Per arrivarci, gli uomini hanno dovuto modificare i loro comportamenti primordiali innati, hanno dovuto inventare un linguaggio di segni, a partire dal sorriso, per significare la deposizione dell’aggressività e la disposizione a cooperare. Hanno creato istituzioni sempre più complesse per articolare e tutelare le relazioni fra di loro, per contenere la violenza, per condividere fini. Quella fiducia che, malgrado l’attuale degrado, caratterizza ancora l’ambiente sociale in cui viviamo rendendo possibili quelle innumerevoli interazioni fra estranei che riempiono la nostra vita di tutti i giorni non è un dato primario, “naturale”, bensì il frutto consolidato di un’infinità di atti di scambio e di cooperazione.
La globalizzazione sta portando alle estreme conseguenze, alla sua massima estensione, questo lungo processo di costruzione di un’unica umanità planetaria. Era inevitabile che questo processo avanzasse in mezzo a timori, incomprensioni, reazioni difensive, di ripulsa. Era ed è inevitabile che esso richieda l’elaborazione di strumenti culturali aggiuntivi, di nuove forme istituzionali per renderlo accettabile e condiviso. Ma lo scenario che oggi ci troviamo di fronte è diverso e più preoccupante. È come se, in prossimità del raggiungimento di questo approdo supremo della nostra civiltà, le tensioni che questa trasformazione provoca fossero sul punto di far saltare l’intero processo, precipitando l’umanità in una sorta di caos sociale primordiale. Il ritorno prepotente della violenza, del terrore, della sopraffazione, della guerra, come strumenti di regolazione dei rapporti fra estranei e, per converso, il rinserramento nelle identità ataviche a tutela di interessi materiali che atavici non sono, bensì frutti avvelenati della modernità, la resurrezione prepotente del nemico che è “legittimo” annientare: sono tutti sintomi inquietanti di un regresso della nostra civiltà, capace di metterne a rischio la sopravvivenza. L’esaltazione della disuguaglianza e l’ossessione per il diverso non ne sono che una delle conseguenze più insidiose e distruttive.
Un nuovo paradigma?
I frutti non sono più a portata di mano, non basta sollevare il braccio e afferrarli per poterne godere. I frutti che rimangono sono ormai in alto e forse non sono accessibili a tutti. Occorre attrezzarsi per coglierli e farli fruire all’intera umanità. Occorre un nuovo paradigma tecnologico, che consenta di condividere i progressi, e un nuovo patto sociale che includa l’ambiente in cui viviamo e contrasti la crescente polarizzazione della società. La difficoltà crescente nel cogliere i frutti dello sviluppo ha fatto emergere con forza la nozione di limite, che è connaturata alla condizione umana. Una nozione che la sapienza antica ha riconosciuto per tempo, facendone il fulcro di una concezione realistica quanto pessimistica dell’esistenza umana, ma che una superba quanto vana ideologia del progresso ha tentato di cancellare nelle nostre mentii senza riuscire a cancellarla nella materialità del mondo fisico. Il senso del limite deve tornare a ispirare i nostri comportamenti, a dettare le regole della convivenza. L’economia è l’ambito principale in cui va affermato.
I nostri costrutti mentali cambiano molto lentamente, e ancora più lentamente cambiano i nostri comportamenti, perché prima che i mutamenti che si verificano nell’ambiente provochino reazioni stabili e durature occorre che vengano sperimentati ripetutamente e che ne venga pienamente percepita la portata. Questo avviene, per lo più, sotto l’influenza di eventi traumatici che ci toccano direttamente. Questo vale sia per l’ambiente fisico che per l’ambiente sociale. È richiesto un senso di responsabilità più maturo ed evoluto, che contempli non solo il riconoscimento e il rispetto dell’altro, ma di tutto ciò che ci circonda sulla nostra terra. Compito immane, per istituzioni che ancora non ci sono, in un mondo in cui la civiltà sembra aver perso la bussola. Siamo cresciuti nell’illusione di essere diventati i padroni del mondo, di poter disegnare a nostro piacimento il mondo fisico e quello sociale. Non è così. Possiamo solo provarci, interagendo, ma senza la certezza di quello che sarà il risultato delle nostre azioni, che sarà sempre anche il risultato di circostanze che non conosciamo e non controlliamo.
Possiamo, e dobbiamo, partire dalla cura e dal rispetto del nostro territorio e della nostra comunità, dalla consapevolezza ritrovata dei limiti non valicabili, dalla riscoperta dei sentimenti e dei comportamenti che ci fanno essere animali sociali, dobbiamo tornare a fidarci degli estranei; ma la strada è lunga e incerta e il tempo breve.