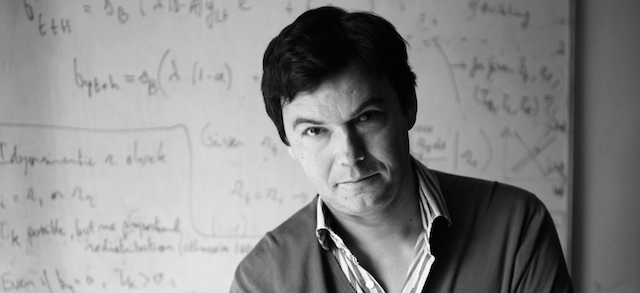Abbattere la disuguaglianza: un tetto alle retribuzioni dei top manager
di Lapo Berti –
 Le retribuzioni dei top manager del settore bancario non devono superare il limite di 20 volte la retribuzione media del resto dei dipendenti. Lo chiede un documento delle associazioni del credito. Per la prima volta viene toccato un tema su cui ancora ci si limita a fare scandalismo giornalistico, invece di intervenire con proposte e misure che pongano rimedio a una delle più drammatiche ingiustizie che ci consegna la crisi attuale.
Le retribuzioni dei top manager del settore bancario non devono superare il limite di 20 volte la retribuzione media del resto dei dipendenti. Lo chiede un documento delle associazioni del credito. Per la prima volta viene toccato un tema su cui ancora ci si limita a fare scandalismo giornalistico, invece di intervenire con proposte e misure che pongano rimedio a una delle più drammatiche ingiustizie che ci consegna la crisi attuale.
Nell’anno 2010 il rapporto tra il compenso percepito da un lavoratore dipendente e un AD è stato di uno a ottantasei nel settore del credito (con picchi oltre le cento volte) e di uno a centodieci nell’economia nel suo complesso. Non siamo ai livelli massimi dell’economia mondiale, dove la retribuzione di un top manager può essere 900 volte quella di un lavoratore medio, ma ce n’è abbastanza perché anche qui suoni un campanello d’allarme.
Il 15 marzo scorso le segreterie nazionali delle associazioni del credito hanno inviato al Presidente del consiglio, al Governatore della Banca d’Italia e al Presidente dell’ABI una lettera in cui chiedono che venga posto un limite al divario fra le retribuzioni dei manager del settore bancario e quelle dei semplici dipendenti . Nella lettera, tale limite di “sostenibilità” della disuguaglianza è fissato a 20 volte.
A parte la misura con cui l’attuale governo ha posto il limite di 300.000 alle retribuzione percepite dai manager della Pubblica amministrazione, è la prima volta, per quanto ne so, che si affronta direttamente il problema dell’abnorme disuguaglianza fra i redditi percepiti dai manager delle grandi imprese e e quelli dei comuni lavoratori.
Un divario, anche consistente, fra le retribuzioni di queste due categorie c’è sempre stato, naturalmente, ma è solo negli ultimi decenni dominati dalla versione neo-liberale della parola d’ordine “Arricchitevi!”, che esso ha raggiunto il livello di guardia, segnalando che nei nostri sistemi economici c’è qualcosa che non va. Un sistema che produce al proprio interno queste intollerabili, e ingiustificate, differenze di reddito e, quindi, di ricchezza fra coloro che ne fanno parte e che contribuiscono variamente al suo mantenimento, alla fine è destinato a implodere di fronte all’incapacità di mantenere un ordine sociale degno di questo nome. Tutte le statistiche mostrano, infatti, una stretta correlazione fra il livello di disuguaglianza che domina in un certo paese e i problemi sociali che esso si trova ad affrontare: dal basso livello di fiducia alle malattie mentali, dalle aspettative di vita e la mortalità infantile all’obesità, dagli omicidi al numero dei detenuti, dalla riuscita scolastica alla mobilità sociale.
Non basta la ricchezza in sé a risolvere o ad attenuare i problemi sociali. Occorre anche che sia distribuita in maniera sufficientemente egualitaria. E’ quanto ci mostrano le statistiche che mettono costantemente in cima alle classifiche dei paesi che meglio affrontano i problemi sociali quelli che non solo hanno elevati livelli di reddito e di ricchezza, ma li distribuiscono in maniera egualitaria fra le diverse categorie di cittadini. Il drappello dei paesi virtuosi comprende, in ordine, il Giappone, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, il Belgio, l’Austria, la Germania. Non cercate l’Italia fra questi, perché essa tende a stare con quelli meno virtuosi, in cui la distribuzione del reddito è più disuguale, il Portogallo, gli Stati Uniti, la Grecia, la Nuova Zelanda.
Se ne ricava una morale semplice da enunciare, ma difficile da mettere in pratica, specialmente nei paesi, come il nostro, in cui una politica debole e alla disperata ricerca di consenso non può permettersi scelte drastiche in termini di tassazione. Se si vuole uscire dalla crisi, da questa crisi, e incamminarsi verso un ordine economico e sociale protetto dagli eccessi cui abbiamo assistito, occorre dedicare molta attenzione alla distribuzione del reddito e della ricchezza. La riduzione della disuguaglianza è il modo più efficace e immediato per migliorare la qualità della vita di tutti noi e anche la qualità dell’ambiente sociale in cui viviamo.
Fissare un tetto massimo al divario fra le retribuzioni dei top manager e quelli della media dei lavoratori può essere un primo passo, può essere un segnale, un modo forte di attirare l’attenzione su di un problema che sta dissestando gli equilibri sociali, oltre che ponendo in questione l’efficacia dell’ordinamento democratico delle nostre società. Ma non può essere la soluzione definitiva. Prima di tutto perché non si può affidare alla contrattazione fra parti sociali la fissazione di condizioni e parametri che hanno a che vedere con il bene comune e ne definiscono i contenuti. Una contrattazione fra parti sociali, per quanto animata dalle migliori intenzioni, è sempre esposta al rischio di scambi politici che, per quanto legittimi in ambito sindacale, non lo sono quando si devono fissare le regole che governano una comunità nel suo insieme. Occorre, quindi, aprire una stagione di riflessione collettiva e di dibattito pubblico in cui porre il problema di un nuovo modello economico e sociale e di un nuovo patto sociale che consenta di affrontarlo.
L’iniziativa delle associazioni italiane del credito è, comunque, da salutare con favore e da sostenere con forza, perché pone sul tavolo un problema di fronte al quale nessuna forza politica che aspiri a guidare l’uscita dalla crisi che stiamo attraversando potrà sottrarsi o evitare prese di posizione chiare ed esplicite. Da questa crisi di sistema si esce stabilmente soltanto se riesce a indirizzare l’economia capitalistica entro un sistema di regole che definisca, in primo luogo, i limiti, anche di rango costituzionale, che vanno posti all’esercizio del potere economico in mani private. Il potere economico dev’essere strutturalmente separato dagli altri poteri che governano la società e posto in condizione di non interferire con il loro equilibrato esercizio. Il primo passo in questa direzione sta nell’evitare che gli uomini che si trovano a gestire il potere economico privato e pubblico lo sfruttino a fini personali, per creare disuguaglianze che la società non è in grado di tollerare, perché minano le basi della coesione fra gli individui. Il secondo passo, ancora di là da venire, sarà quello di regolare le dimensioni delle imprese economiche in modo da porle in equilibrio con le capacità di governo nazionali e sovranazionali. Non è più tollerabile, infatti, che formazioni economiche private possano accumulare un potere di condizionamento economico e, quindi, anche politico, capace di fronteggiare e, talora, di sovvertire le decisioni dei governi. Sono questi, crediamo, i primi punti nell’agenda politica del nuovo millennio.