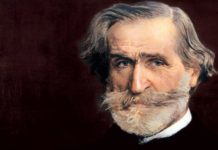L’antropologia della crisi
di Aldo Bonomi –
 Recentemente mi sono trovato a ragionare con l’antropologo Marc Augé del suo libro Diario di un senza fissa dimora, un breve testo scritto in prima persona nel quale si racconta l’esperienza di caduta ed esclusione sociale di un simbolo del ceto medio metropolitano francese: il funzionario pubblico parigino.
Recentemente mi sono trovato a ragionare con l’antropologo Marc Augé del suo libro Diario di un senza fissa dimora, un breve testo scritto in prima persona nel quale si racconta l’esperienza di caduta ed esclusione sociale di un simbolo del ceto medio metropolitano francese: il funzionario pubblico parigino.
Le circostanze che lo portano a trasferirsi dal comodo appartamento in affitto alla sua vecchia Mercedes sono presto dette anche per uno che riceve una pensione di 2mila Euro: rincaro dell’affitto, due separazioni alle spalle ad alimentare il circuito autoescludente della solitudine. Dopo avere vissuto da senza fissa dimora e averci proposto le riflessioni sui paradossi della vita vista dal di “fuori” da uno che era stato sempre “dentro”, il nostro protagonista assume la decisione di “andare verso la Senna”. Non sappiamo, e non lo sa neanche l’autore come da mia domanda, se quella è stata la sua ultima decisione o meno. Non è mai detta l’ultima parola in questi casi, o almeno così vorremmo. Fatto è che il racconto da antropologia della crisi di Augé (più utile in questa fase della strumentazione sociologica) non parlava di un clochard con “i scarp de tenis” condannato alla sopravvivenza da quella che un tempo avremmo denominato come “condizione di marginalità cronica”, ma piuttosto di un simbolo positivo di integrazione della società francese. Qualche giorno dopo avere ascoltato il racconto di Augé la cronaca della disperazione ha pensato bene di consegnarci il traslato italico della crisi che tocca e travolge figure sociali simbolo di un’epoca. Solo che questa volta non era etnofiction, e, soprattutto, il finale non è rimasto aperto, ma si è chiuso in un’umida cantina marchigiana. Là dove si è consumata la tragedia di una coppia, cui si è aggiunto poco dopo il fratello della moglie, che ha concertato di farla finita dopo avere sperimentato, in particolare in questi ultimi anni di avvicinamento e approdo all’agognata pensione, un’inaspettata discesa agli inferi della povertà. So bene che esiste sempre un margine di insondabilità nelle vicende personali che portano a questo tipo di decisioni e che non esistono, meno male, leggi deterministiche che tracciano i destini dei singoli. Ma a volte i singoli e le loro decisioni diventano simboli che “parlano” di noi, di noi che magari non siamo stati capaci di cogliere il profondo disagio quando parlavano a noi. Sul piano simbolico la vicenda di Civitanova Marche ci parla della profonda crisi di solitudine che investe una figura emblematica del modello di sviluppo italico fondato sulle tante comunità territorializzate nei distretti industriali della Terza Italia, quella del mitico “metalmezzadro”, nella versione dell’operaio del calzaturiero e del manovale nel ciclo dell’edilizia. Una figura sociale che è stata perno delle comunità operose e intorno alla quale si è costruita la misconosciuta epopea di emancipazione dalla povertà contadina e poi di diffusione del benessere in tante parti del Paese. Un modello di sviluppo che ha saputo coniugare, non senza dialettica, l’operosità del contado con il civismo municipale delle cento città. Intendendo con ciò anche l’affermazione di un principio di coesione sociale imperniato sul legame comunitario più che sui diritti sociali sanciti dalla statualità. La crisi di questo modello non è questione di piccole e fredde passioni economiche. La questione, come ci ricorda anche quanto accaduto a Civitanova, è pre-economica, antropologica e sociale. Nella metamorfosi della crisi si sta ridefinendo in profondità l’antropologia delle 3C (casa, campanile, capannone). La casa, quella della famiglia che teneva insieme cura e operosità in un circuito allargato alla comunità, appare sovraccaricata e sola perché sono a rischio le reti corte di prossimità attraverso le quali compensare il peso di una crisi che sfonda con violenza la porta del capannone, facendo coriandoli di tanti piccoli imprenditori e di tantissimi operai. Coriandoli che tentano non di rado la via del “fare da sé”, dell’autoimpiego a partita IVA “per necessità” come nel caso di una delle tre vittime di Civitanova, in una coazione a ripetere che non è altro se non l’estremo tentativo di adattamento nel percorrere la sola via che si conosce, senza che nessuno ti venga in aiuto per allargare un po’ l’orizzonte della speranza. Del campanile non è necessario qui parlare, basti qui ricordare su quanto abbia da subito insistito il nuovo Papa in tema di rilancio della missione pastorale per comprenderne la crisi epocale. Insomma il modello del capitalismo molecolare appare senza più protezioni, chiuso nella ridotta famigliare, talvolta schiacciata da una comunità della quale si percepisce solo il potere sanzionatorio della vergogna per il fallimento, ma non più la capacità propulsiva di produrre speranza collettiva. Così si allarga la voragine della povertà e si moltiplicano i comportamenti resistenti che possono spezzare le volontà di chi scambia per propria debolezza la potenza di elementi di cui non si percepisce se non un’oscura indifferenza al proprio destino. Così l’”uomo indebitato” diventa la trasfigurazione tragica della solitudine dell’imprenditore molecolare. Da questo punto di vista mi pare quanto mai sacrosanto il principio per il quale oggi “la politica è dire al tuo prossimo che non è solo”. Si tratta però di una condizione necessaria per riallacciare i fili della resilienza ma non sufficiente per immaginare un nuovo DNA ricombinante che ponga le basi per tenere assieme ciò che non è più, ovvero il motore propulsivo della piccola impresa di matrice comunitaria, con ciò che non è ancora, ovvero il contributo fondamentale dei giovani per la modernizzazione e la civilizzazione nella metamorfosi.
Tratto da “Microcosmi”, Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2013